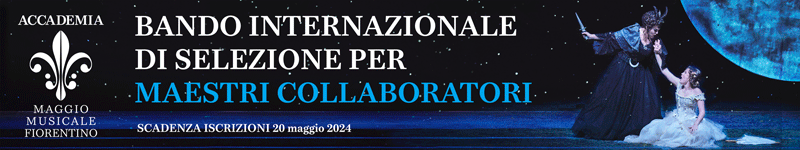Attila, luce e natura
Quando Verdi si accinge a comporre Attila, tratto da un dramma di Zacharias Warner, è un baldo trentatreenne con alle spalle otto debutti operistici tutti in teatri prestigiosi. Con l'eccezione della commedia Un giorno di regno, tutti soggetti storici o esotici, spesso con importanti presenze corali, in cui il tratteggio di regnanti, banditi, nobili e guerriere ha offerto un'eccellente palestra per affinare gli strumenti per sondare l'animo umano, i rapporti familiari, affettivi, sociali e politici. E il tema politico ricorrente nell'Ottocento romantico che si prepara al Risorgimento è quello dello scontro fra oppressi e oppressori, possibilmente vigilato da una manzoniana Provvidenza e non dalla disincantata e disinteressata Natura leopardiana. Ma proprio alla Natura ricorre con un'attenzione finora inedita il giovane Verdi nel 1846 nel progettare il suo Attila per il teatro La Fenice di Venezia. Anzi, alla messa in scena comincia a prestare un'attenzione maniacale, intuendo che quella spettacolarità che è sempre stata parte integrante e fondamentale dell'opera lirica si sta evolvendo verso una nuova idea di teatro. Così studia l'iconografia, si fa inviare copia dell'affresco di Raffaello con l'incontro fra Attila e papa Leone I nei palazzi vaticani per trarne ispirazione (e di fatto la visione nel finale del primo atto descrive esattamente l'immagine nella sala di Eliodoro), ma soprattutto s'interessa alla scenotecnica, alle luci, così fondamentali in rapporto alla musica per restituire l'elemento naturalistico come elemento drammaturgico. La tempesta e l'alba nel finale primo, emblema dei tempi cupi e difficili da cui sorge qual "fenice novella" una nuova speranza, è uno dei momenti a cui tiene di più, come la festa degli Unni illuminata da torce che un soffio di vento spegne improvvisamente balzando la scena nell'oscurità.
Con Attila, Verdi, dimostra, insomma, come la teatralità sia parte integrante del suo linguaggio, di un messaggio affidato alla musica come all'immagine. Il passo successivo, dopo questa ricerca storica e naturalisticha che pure ammette, con l'apparizione di Leone, elementi mistici, sarà Macbeth, per il quale Verdi sonderà la sfera del sovrannaturale fra spettri, visioni, sortilegi che lo spingeranno a svolgere continue ricerche sugli ultimi ritrovati in campo di macchine teatrali, illuminotecnica, lanterne magiche utilizzate in scena come antenate delle moderne proiezioni. Si mette alla prova lo spirito avanguardista di Verdi, che scrive le sue note "belle o brutte che siano" sempre con una ragione e un carattere, e che queste ragioni e questi caratteri li trova nel teatro, nel ritmo incalzante di un'opera per molti versi belcantista che sembra quasi chiudersi su sé stessa, quasi risucchiata dalla rapidità di un dramma che rende ogni atto più breve e fulmineo del precedente. E li trova anche nello scandalo del teatro, con un gobbo in scena, delle streghe gracchianti o l'incantesimo dell'alba dopo la tempesta sulla laguna di Venezia.