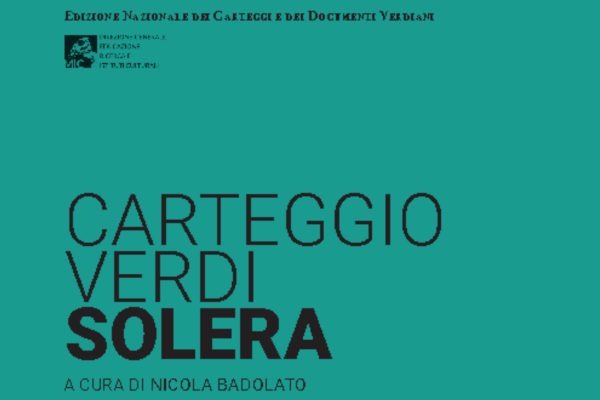Dietro il silenzio
Carteggio Verdi Solera
a cura di Nicola Badolato
LVII + 142 pagine e XIV tavole
ISBN 979-12-8110-700-7
2025, Edizione Nazionale dei documenti e dei carteggi verdiani, Istituto Nazionale Studi Verdiani
L'ultimo nato della collana dei carteggi e dei documenti verdiani, quello dedicato a Temistocle Solera, è anche il più smilzo, ma la dimensione fisica non tragga in inganno sulla sostanza del lavoro che, anzi, arriva a indagare in maniera illuminante il silenzio. Dapprima, un silenzio brulicante di vita, ché se le lettere risalenti alle collaborazioni per Oberto, Nabucco, I lombardi e Giovanna d'Arco sono poche, ciò dipende dal fatto che gli incontri di persona erano più facili e frequenti. Le cose cambiano un po' con Attila, che infatti, per il trasferimento del librettista in Spagna e la sua scarsa prontezza nelle risposte, verrà poi completato dal fido Piave: dopo di ciò seguirà un lungo silenzio, almeno da parte di Verdi. Solera continuerà a scrivere assiduamente in un soliloquio senza – o quasi – risposte, cosa che non può non balzare all'occhio se si pensa anche ai tanti esempi di amicizia e generosità che costellano la vita del compositore. Come fu vicino alle famiglie di Somma e Piave nel momento del bisogno, così ignora Solera: perché? Se la carenza di documento, talvolta vaghi o contraddittori, stuzzica lo studioso, la particolarità del personaggio appassiona ogni lettore.
Bresciano di famiglia e ferrarese di nascita, dopo la condanna del padre patriota allo Spielberg il giovane Temistocle ottiene con il fratello una borsa di studio “riparatrice” dal Kaiser a Vienna, ma, inquieto e orgoglioso, fugge e si unisce a un circo equestre gitano per il quale scrive i primi testi. Oltre che librettista, poeta e giornalista, tenta anche, con una manciatina di titoli, la strada della composizione; sposa il soprano Teresa Rusmini e con lei in Spagna si arrischia anche come impresario. Nel mentre, si dà alla diplomazia e allo spionaggio, si vocifera di una sua relazione con la regina Isabella II di Borbone, in Italia segue le orme paterne e collabora con Cavour, è nominato questore, viene scritturato da Isma'il Pasha (il committente di Aida) per creare in Egitto un corpo di polizia sul modello europeo. Le cose, tuttavia, in questo turbinìo avventuroso e un po' confusionario non gli vanno benissimo, finisce più volte in bancarotta e fra i suoi mestieri, oltre al copista in studi legali, c'è anche quello del portatore d'acqua. Negli aneddoti dei primi anni, che possono aver contribuito a spazientire Verdi come l'inconcludenza delle vicende successive, lo vediamo sottrarre “distrattamente” qualche pagina verdiana per completare la propria opera Ildegonda o venir chiuso dal compositore in uno stanzino per stendere le strofe necessarie per musicare una scena (e per vendetta, trovato l'armadio dei vini, scrivendo il Nostro dava fondo alla riserva alcolica del maestro). Da qui, poi, la vita di Solera prende una piega quasi fantozziana, tragicomica: l'impresa di sgominare la banda di briganti che aveva sequestrato una nobile dama riesce – a leggere l'entusiastica agiografia firmata dalla figlia Amalia – ma a prezzo della vita del povero ostaggio, freddato per un incauto segno d'intesa rivoltole dal "salvatore"; l'incarico egiziano si conclude in un nulla di fatto con un rapido rientro degli italiani ad Ancona; la prospettiva del ritorno alla scrittura per il teatro musicale si spegne allorché il compositore interessato a un suo libretto viene rinchiuso in manicomio.
Verdi, frattanto, continua a tacere. Forse invia qualche sintetico bigliettino, tramite Giuseppina nega la sua disponibilità a conoscere l'ultima fatica di Solera, un libretto che troviamo riprodotto nel volume e che, in effetti, non sembra l'occasione mancata per un capolavoro. Decisamente fuori tempo massimo, questo Amore e arte recupera la temperie semiseria e mescola il presupposto di Kabale und Liebe (Luisa Miller) – il sentimento fra una giovane popolana e un nobile rampollo, l'orgoglio di casta del padre di lui e la dolce saggezza del genitore di lei – con una morte apparente e una pazzia maschile guarita in una rappresentazione del mito di Pigmalione e Galateache conduce al lieto fine. Molto ambizioso, un po' ingenuo, fa quasi tenerezza: davvero pensava di affidare a questo improbabile idillio un riscatto e un rinnovato successo l'autore dei versi di Nabucco? Un autore che intorno agli anni '40 aveva dato prova di un gusto audace, di un romanticismo in vera rotta di collisione rispetto alle consuetudini poetiche classiche, magari meno sofisticato rispetto ai più anziani Di Breme, Berchet, Maffei, non geniale come il futuro Boito, ma dotato di indubbia immediatezza teatrale e certo posto sulla medesima loro linea nel non temere il grottesco, il brutale, il bizzarro. Vien da pensare che la collaborazione con Verdi abbia giovato agli esiti più felici del Solera librettista, ma (senza arrivare agli eccessi dell'affettuosa figlia biografa che dipinge Temistocle intento a spronare verso i grandi cori patriottici il timido e riguardoso Giuseppe) nondimeno possiamo dare al poeta quel che è del poeta: uno slancio drammaturgico e letterario non trascurabile, per quanto dissipato poi nel caos di una vita avventurosa.
Più che direttamente della genesi delle opere scritte con Verdi, i documenti e i carteggi di Solera ci raccontano altro, non meno importante. E, a dispetto dell'assenza pressoché totale di scritti del compositore, il volume non è per questo povero di primizie, dagli scambi epistolari con Ricordi, alle citate note biografiche redatte dalla figlia a quelle giornalistiche dedicate alla moglie Teresa Rusmini, fino al testo integrale di Amore ed Arte. Grazie anche alla disponibilità degli eredi Solera, Nicola Badolato, curatore del volume, ha svolto un lavoro veramente eccellente (né vanno dimenticati i contributi di Andrea Malnati, redazione, e il comitato scientifico presieduto da Fabrizio Della Seta).
Un lavoro la cui rilevanza culturale non si limita alla trascrizione ragionata e sistematica di documenti utili agli accademici musicali (e già questo sarebbe importante), ma si estende in un più ampio raggio, né può fermarsi: se la scoperta di nuovi documenti non è mai da escludersi, sono soprattutto le modalità e le prospettive di studio e ricerca a evolversi nel tempo e a suggerire nuovi punti di vista. Spiace constatare che, invece, la legge italiana preveda il sostegno per queste edizioni nazionali solo per un lasso di tempo predeterminato spesso non corrispondente alle esigenze. Il termine ministeriale per i carteggi verdiani sarebbe già scaduto, se non ci fosse stata una proroga legata alla pandemia, e pur lavorando a pieno regime l'immane mole del piano della collana è ancora ben lungi dal vedere la fine: basti pensare, a fronte della smilza corrispondenza con Solera, alla quantità di documenti oggetto del futuro volume dedicato a Francesco Maria Piave. Né si dimentica che lo scandalo dell'abbandono di Villa Verdi comporta anche il blocco nell'accesso a vari materiale.
L'Istituto Nazionale Studi Verdiani sta svolgendo un lavoro straordinario e sarebbe bello che qualcuno al Ministero lo riconoscesse e ne comprendesse anche le modalità e le esigenze pratiche.
Leggi anche
Libri, Sala, Opera, neutro plurale
Libri, Del Corno, Puccini '900
Libri, Della Seta, Bellini - Zoppelli, Donizetti - Chegai, Rossini